Il nemico
Tratto da “La mia terza cuccìa” di Pasquale Carelli
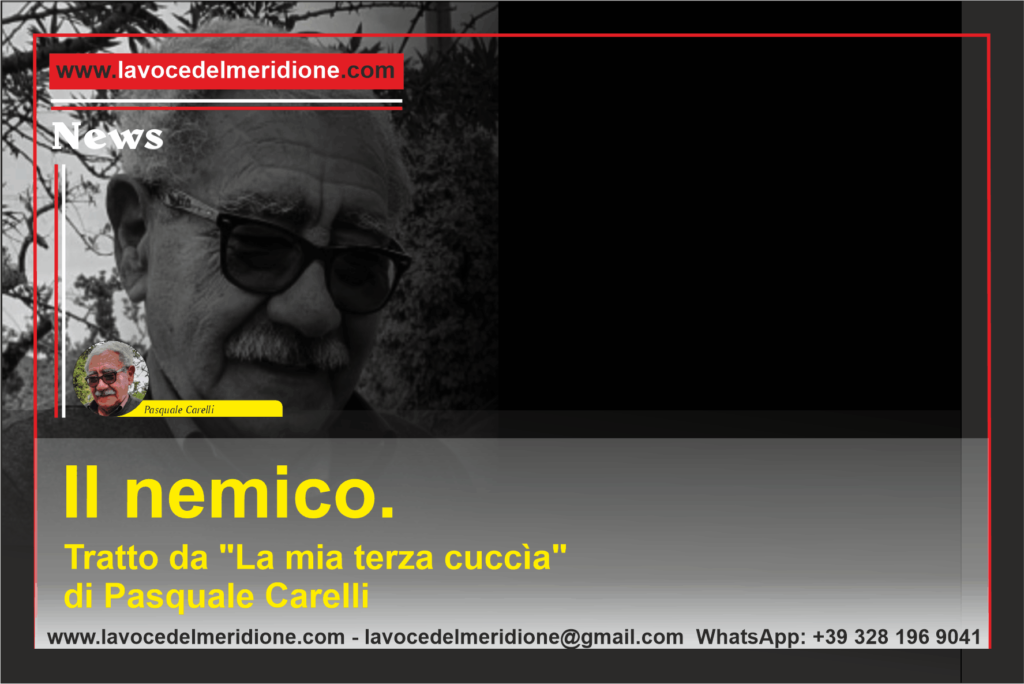

I Racconti di Pasquale Carelli
L’uomo ci cadde dal cielo. Se cielo poteva chiamarsi quell’impasto di grigi che da giorni soggiogava la valle. Era un’aria d’attesa, come stesse a predirci che qualcosa poteva, doveva accadere. Anche la nebbia sembrava ammonirci da giorni, con quel suo troppo indugiare sdraiata sul greto del fiume, allungando le bave su pei costoni a ghermire alberelli stecchiti, a lambire perfino i muri meschini delle case più in basso, che anch’esse aiutavano a far della guglia di roccia un paese. E noi eravamo lassù, nell’incertezza dell’alba: tutti gli uomini avanzati alla guerra, le donne sgomente e i fanciulli ancora coi sogni negli occhi.
Troppo forte era stato il lamento dell’aereo passato sui tetti. Una mezza dozzina di sguardi l’avevano visto tale e quale ingoiare dal lago di nebbia, e spegnersi lì tutto lo strazio del motore ammalato, come un ferro rovente che si tuffi nell’acqua.
“Che facciamo, don Paolo?” mi chiese qualcuno.
“Si scende a vedere… cos’altro?”
La voce si sparse: a un prete si crede, in certi momenti.
Scendemmo la costa con poche parole e, giunti sul greto del fiume, ci bastò qualche passo nell’arena bagnata per sentire: “Eccolo! E’ grande! E’ laggiù!” Era stato Cenzino a vederlo per primo.
La nebbia si alzò tutta d’un tratto, quasi che la nostra presenza l’avesse turbata. L’aereo, cento metri più avanti, non aveva più magia né arroganza; se ne stava piegato da un lato, con un’ala spezzata, quasi tutta nell’acqua. Perciò non ci volle coraggio a toccarlo, a forzare il portello e cacciar fuori il pilota. Era soltanto svenuto, due fili di sangue già raggrumati sul collo. Michele se lo caricò sulle spalle, felice di ostentare una forza che la guerra non aveva voluto: era quasi un gigante, Michele, ma aveva assai poco cervello, così poco che ci volle del bello e del buono per fargli posare il pilota sulla barella arrangiata coi legni del fiume. Voleva portarselo lui, fin sopra al paese.
Attilio, dai cento mestieri, e che la domenica mi serviva la messa, mi soffiò in un orecchio: “Don Paolo, quello è un nemico!”
Gli risposi che anch’io avevo gli occhi sotto la fronte, poi gli dissi un po’ duro di dare anche lui una mano ad un angolo della barella, e di farlo in silenzio, che il fiato serviva a salire il viottolo appeso. Per fortuna, ancora nessun altro parlava, anche se più di un occhio indugiava sulla giubba del soldato caduto, sulla manica, in alto. Pensai che in tempo di pace una bandierina così avrebbe fatto soltanto allegria; invece, in quegli anni che ci toccava la guerra, quel rettangolo sulla divisa diventava minaccioso e tremendo, e i colori stranieri accecavano fin dentro la mente. Fu per questo che giocai di prudenza e feci sistemare il soldato nella nostra piccola chiesa.
Riprese i sensi del tutto sotto gli occhi del Cristo di legno; ebbe un attimo di grande sgomento, poi ci vide e riprese colore. Dopo un sorso di vino volle alzarsi e fare dei passi, con due ali di folla sui banchi. Disse qualcosa: nessuno capì le parole ma, sarà stato il suo timbro di voce o gli echi di chiesa, tutto suonò troppo straniero, e la gente cominciò col guardarlo di sghembo. Fui lesto a trovare una buona bugia. “Ha detto che ci ringrazia per averlo aiutato.”
Ma il solito Attilio non se la bevve; mi sfidò, avanti a tutti, a parlare al pilota, se conoscevo lingua. Gli risposi ch’era meglio lasciarlo un po’ in pace. Mugugnando, uscirono tutti. Con me rimase soltanto Michele; non ci fu verso di fargli lasciare la chiesa; per la sua semplice mente, quell’uomo era un po’ roba sua: giù al fiume se l’era tenuto sul collo un bel pezzo, come usava portare i capretti. Forse, tra l’altro, gli suggeriva quest’idea di possesso anche lo sguardo del pilota nemico: occhi smarriti, e chiari come il marmo dell’acquasantiera.
Il soldato si mise a parlarmi con le mani e con gesti del viso; mi faceva capire che non poteva restare, che doveva andar via. S’era accorto che là fuori qualcosa bolliva. Infatti, si sentì presto un colpo al portone. Gridai: “Che succede?”
Una voce che non riconobbi, tanto era eccitata, rispose: “Lo vogliamo!”
“Questa è la casa di Dio!” esclamai con una voce di predica e rabbia.
“Appunto, noi lo vogliamo qua fuori, don Paolo!” Questa volta riconobbi chi aveva parlato, era stata una donna assai buona ma vedova dal primo anno di guerra; fu proprio questo che mi fece tremare. Anche Michele aveva capito qualcosa, e dava uno sguardo al portone e l’altro al suo capretto caduto dal cielo.
Poi, là fuori, non parlò più nessuno. Cominciò un gran silenzio, ma non era un buon segno. Pensai che adesso c’era da attendersi il peggio.
Fu Attilio, dopo un poco, a gridare che avrebbero atteso non più di un minuto, disse anche che una fortuna così non si poteva lasciarla scappare. Gli risposi che soltanto una bestia poteva pensarla in quel modo. Il pilota s’inginocchiò sotto i piedi del Cristo e si mise a pregare; anch’io chiesi al Signore che facesse qualcosa.
Puntuali cominciarono i colpi al portone; dapprima solo pugni e spallate, poi arnesi di ferro, rubati al buon uso dei campi. Presto furono dentro, con gli occhi di brace. Mi travolsero senza nemmeno vedermi; a Michele usciva sangue dalla bocca e dal naso; Attilio brandiva una corda di pozzo. Chiesi a Dio perché non volesse ascoltarmi, perché non volesse salvare quell’uomo né quei poveri ciechi. E gridavo, anch’io cieco alla fede, scordando la tonaca ed ogni preghiera, inseguendo e maledicendo quella folla di uomini donne e bambini… fino all’albero che avevano scelto.
La corda era pronta; ora aspettavano tutti in silenzio, e sembrava che stesse lì per morire ogni traccia di vita, come se il cappio fosse pronto non al collo del nostro nemico ma a tutta la valle, fino alle più lontane colline. E dalle colline cominciò a crescere il tuono, sempre più forte; parve a tutti la voce dell’ira di Dio. Era invece un aereo, gemello di quello caduto nel fiume: si abbassò così tanto che lesse i pensieri di ognuno. Girò due o tre volte, poi fece cadere una bomba dentro un crepaccio lontano, perché non colpisse nessuno ma che capissimo tutti: si doveva liberare il nemico caduto dal cielo, sennò del paese sarebbe rimasta soltanto una grande rovina di pietre. Io stesso tolsi la corda al pilota; negli altri, la vendetta s’era fatta terrore, di quello che lascia le gambe e le braccia di piombo.
Sempre a gesti, il pilota mi fece capire che dovevamo ridiscendere al fiume, che soltanto in quel poco di piano l’aereo poteva atterrare per prenderlo a bordo. Ci avviammo, io e lui solamente, a metà strada ci raggiunse Michele coi suoi passi giganti, c’indicava l’aereo che ci seguiva dall’alto, con le mani, perché non sapeva parlare; poi rimase incantato vedendo quell’uccello di ferro acquattarsi nel greto. Ne discesero alcuni soldati, uno corse veloce all’aereo caduto il mattino, stese un calcio all’ala spezzata, imprecò, poi sparse tutto intorno benzina: non avevo mai visto tanto fuoco a due passi dall’acqua. Col nemico ci salutammo semplice e intenso, con una stretta di mano; alzammo insieme lo sguardo alle case, lui scosse il capo: mi bastò per capire che non avrebbero fatto cadere vendette su quel mucchio di tegole e pietre.
La domenica appresso, la chiesa era piena di ceri, e sui banchi non mancava nessuno. O meglio, qualcuno non era al suo posto di sempre ma in piedi, accanto al mio altare. Michele, fuori di sé dalla gioia, mi serviva la messa: aveva ancora un bel po’ da imparare, ma sapevo di avere vicino i pensieri migliori del mondo.





