Dire la verità
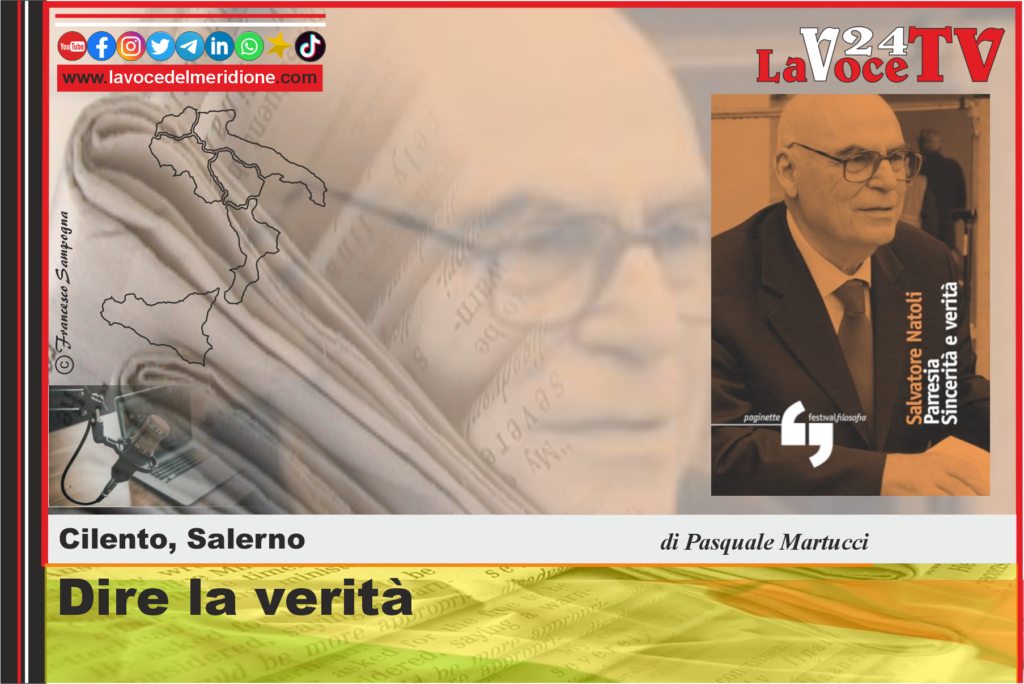

di Pasquale Martucci
“I grandi parresiasti nella storia hanno raramente vinto, per lo più hanno perso, ma la loro voce ha attraversato i secoli”.
(Salvatore Natoli, “Parresia. Sincerità e verità”, paginette festivalfilosofia, ed. settembre 2019)
Quando mi confronto con il concetto di “verità” mi viene in mente il suo contrario: finzione, menzogna, parole vuote e prime di senso purché attrattive ed in grado di coinvolgere e generare consenso, specie quando affidate alle forme di comunicazione offerte dai social media, soprattutto se riguardanti questioni politico-sociali.

Ogni società si è sempre confrontata con la “verità”: alcuni hanno affermato che non esiste; altri hanno parlato di una o tante verità; molti di verità assolute. Questo concetto evoca certezza, autenticità, obiettività, oggettività, giustezza, esattezza, precisione. Si scopre invece che la “verità” lascia più di un dubbio quando cominciamo a domandarci se è vero quel che si dice, se è credibile chi lo dice, se sono fondati modalità e contenuti trasmessi.
Per trovare una strada da percorrere, si può introdurre un termine interessante che riconduce a “verità”: parresia (da pan, tutto, e rema, ciò che viene detto), il parlare chiaro, il dire il vero e senza infingimenti, che molti esponenti del pensiero filosofico hanno utilizzato.
Salvatore Natoli, in occasione del festivalfilosofia del 15 settembre 2018, ha distinto tra “l’essere verità” (aletheia) e il “dire la verità” (parresia). Sul primo termine alcuni si riferiscono al nascondere, per cui “verità” sarebbe il “non nascosto”, ciò che è “disvelato”. Aristotele connette il pensiero alla verità, soprattutto in considerazione dell’oggetto del conoscere e del suo rapporto con l’intelletto, svelando le cose e l’uomo in quanto situato dentro le cose. Heidegger parlava di esserci, essere in un mondo che si muove tra le cose che appaiono in primo piano o sullo sfondo: diventa importante “coglierle nel suo effettivo presentarsi a noi”, perché ci sono tante cose che ci sfuggono o che non ci attraggono. Di conseguenza, quando incontriamo “quella cosa lì”, “quella cosa lì è se stessa”, e così procedendo si può individuare il problema della “verità” esplicitata nella “forma di principio d’identità e non contraddizione”. Ed ancora: quando la cosa ci attrae significa che ci interessa (da essere inter, stare tra le cose) ed “indirizza il movimento del pensiero e lo guida”. L’uomo si interessa di una cosa che ci piace ed allora la vede nella sua evidenza; nell’aprirsi all’esperienza ci approssimiamo ad un ente piuttosto che ad un altro e ne “siamo affetti”, ed allora il movimento verso una determinata realtà è originariamente affettivo. Infine, per queste ragioni, vogliamo attingere la cosa “fuori da ogni confusione”, nella sua verità, da cogliere nel suo eidos, nella sua identità, che è soprattutto combinata con “prospettiva”, ovvero si coglie l’identità secondo una prospettiva.
Non è relativismo, piuttosto, come sostiene Natoli, l’interesse che spinge verso un ente o verso un altro. Si può asserire che il mondo si dipana tra identità e differenze, che si tengono distinte per non cadere nel falso. Per fare tutto ciò occorre frenare, ovvero come sosteneva Husserl “sospendere il giudizio”, purificare il proprio sguardo. Natoli fa riferimenti a Platone (quel che è è, e quello che non è non è), o alla Scolastica (corrispondenza tra intelletto e cosa, identità della cosa con se stessa), o a Galilei a proposito delle verità scientifiche (e teorie che rendono possibile sperimentare, con ripetizioni costanti e invarianti). Infatti, se non c’è teoria che tiene insieme i dati dell’osservazione non è possibile produrre conoscenza scientifica, la generalizzazione dei fenomeni. Un altro filosofo citato è Foucault, quando parla di garanzia di verità, in cui la verità deve essere sempre sotto condizione, mai arbitraria.
Tornando alle argomentazioni precedenti, la “verità” non è mai universale se non nella forma di identità, che sottostà a regole che mettono ordine all’osservazione: è la ricerca della “verità”, il dire-la-verità, dove in gioco è il diritto o il dovere di dirlo.
In questa accezione, le domande sono del tipo: Chi è in grado di dire la verità? Chi la dice deve avere dei requisiti per dirla? La si deve dire sempre o solo in determinate circostanze? Che rapporto c’è tra dire la verità e l’esercizio del potere?
In gioco non è la struttura logica della “verità”, ma la capacità e la forza di dirla.
L’aspetto oggettivo incontra quello soggettivo, come ad esempio il concetto di “sincerità”, cioè dire le cose senza infingimento. L’assunto è che “il sincero non solo non fornisce un’informazione sbagliata, ma non dà alcuna informazione se è convinto di non sapere”. Dunque, il sincero deve sapere ciò che è oggettivamente vero, e la sincerità rientra nell’aspetto oggettivo, nel vero. Ma il sincero può sbagliare, anche se lo fa con intenzione sana: “crede che sia vero, dà un’informazione non corretta, ma non ha intenzione di sbagliare”; ritiene cioè di aver detto il giusto. È il contrario del mentitore che opera con l’intenzione dell’inganno.
Ad ogni modo, la sincerità e la menzogna hanno sempre a che fare con gli altri: nel primo caso, la relazione con l’altro è quella del “non inganno”. Comunque anche il mentitore potrebbe ingannare e dire la “verità”, perché pensa che quella da lui affermata sia una “non verità”.
Il dire la verità porta al concetto di parresia che comporta “l’obbligo di dire la verità” e “dirla pubblicamente”; si tratta di un presupposto etico perché “il parresiasta è tale se ha una motivazione etica e pubblica”, e se non lo fa viene meno alla giustizia, viene meno agli interessi della città (pólis). Quando dice la verità, svela il volto del potere.
Il parresiasta deve avere anche delle qualità personali, essere capace di dire la verità, e di conseguenza possedere alcuni requisiti:
a) essere contro l’ingiustizia;
b) avere il dovere di dire la verità;
c) avere una tecnica per dirla, cioè deve saper parlare.
Secondo la visione di Foucault, chi esercita la parresia deve aprire delle possibilità, deve “far accadere delle cose senza averle previste”. Egli deve anche dire cose non gradite, perché l’obbligo della verità significa anche mettersi a rischio: la prima condizione della parresia è la democrazia; la seconda è l’ascendenza sugli ascoltatori, l’autorevolezza. Che certamente non vuol dire essere autoritario (obbligare qualcuno a fare qualcosa), ma essere in grado di fornire un piano d’azione e risolvere i problemi con capacità di proposta, tecnica e competenza.
L’autorevole però non deve diventare egemone sugli altri, come accade quando si stimolano i bassi istinti della popolazione, seducendo con promesse o “far provare il terrore con la paura”. C’è una parresia buona; quella cattiva non è parresia ma ne ha solo la parvenza.
Occorre perciò agire attraverso un atteggiamento etico, anche perché per governare non basta essere buoni, ma la bontà è certamente una precondizione: “gli onesti in quanto onesti non è detto che possano governare, ma se governano i disonesti, le cose sono sicuramente peggiori” (Natoli).
Nelle attuali società il parresiasta spesso agisce nell’indifferenza, rischia di non essere sentito e ascoltato; la sua parola cade nella confusione dell’incompetenza e quindi vale come tante altre. C’è comunque bisogno di verità, anche se la stessa può non essere condivisa dalla maggioranza, può far male.





