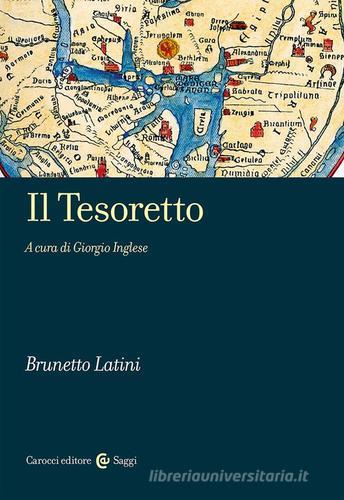Il piacere del testo: “Brunetto Latini tra lingua e politica”
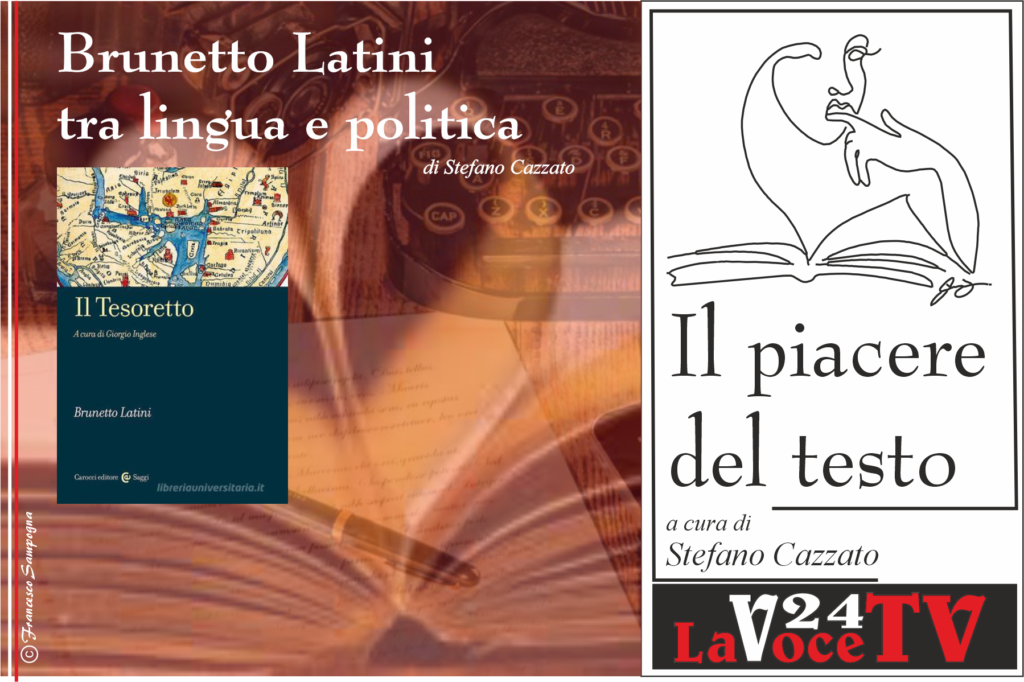

“Il piacere del testo“ a cura di Stefano Cazzato
Anche se il genere è quello enciclopedico (cioè una sorta di compendio universale del sapere umano), il tema di questo poemetto di Brunetto Latini è certamente politico, non solo perché politica è la dedica, ma soprattutto perché l’antefatto, lo smarrimento del narratore in una selva che ricorda lo smarrimento dantesco, sembra essere stato causato dalla notizia della vittoria dei Ghibellini a Firenze e della cacciata dei Guelfi.

Qui inizia un viaggio allegorico, di tremila versi, che il lettore in volgare del 1200 potè compiere in compagnia dell’autore verso la conquista dei beni civili. Un’iniziazione al galateo, alla virtù, alla scienza che si interrompe però (il poema non fu terminato) sulla vetta del monte Olimpo prima che Tolomeo inizi a discutere di fisica.
Quanto al “valente signore di cui non so migliore sulla terra trovare che nonn avete pare né in pace né in guerra, sì ch’a voi tutta terra che il sole gira il giorno e ’l mar batte d’intorno san’ faglia si conviene, ponendo mente al bene che fate per usagio e a l’alto legnagio donde voi sète nato”, potrebbe trattarsi, secondo la critica, di Alfonso X di Castiglia, di Luigi IX di Francia o di Carlo d’Angiò o di tutti e tre assieme.
Brunetto Latini, che fu, tra le altre cose, maestro di Dante Alighieri, professore di retorica nonché uno dei traghettatori della cultura classica al mondo moderno, ebbe importanti incarichi presso il Comune fiorentino, a partire dal 1250 e poi, soprattutto, dal 1267 con la vittoria dei Guelfi.
Il necrologio fatto dallo storico Giovanni Villani nel 1294 dice che “egli fue cominciatore e maestro in digrossare i Fiorentini e farli scorti in ben parlare, e in saper guidare e reggere la nostra repubblica secondo la Politica”. Un educatore, un vate, comunque un protagonista della vita pubblica a Firenze.
Il tesoretto, composto verosimilmente in Francia durante il periodo dell’esilio, è un’importante testimonianza storica, letteraria e linguistica che esce oggi in una nuova edizione del testo rivisto sui manoscritti e corredata da un importante apparato critico.
Brunetto Latini, Il Tesoretto, a cura di Giorgio Inglese, Carocci editore, 2024, pp.202, Euro 21.00