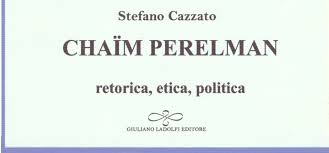Libri
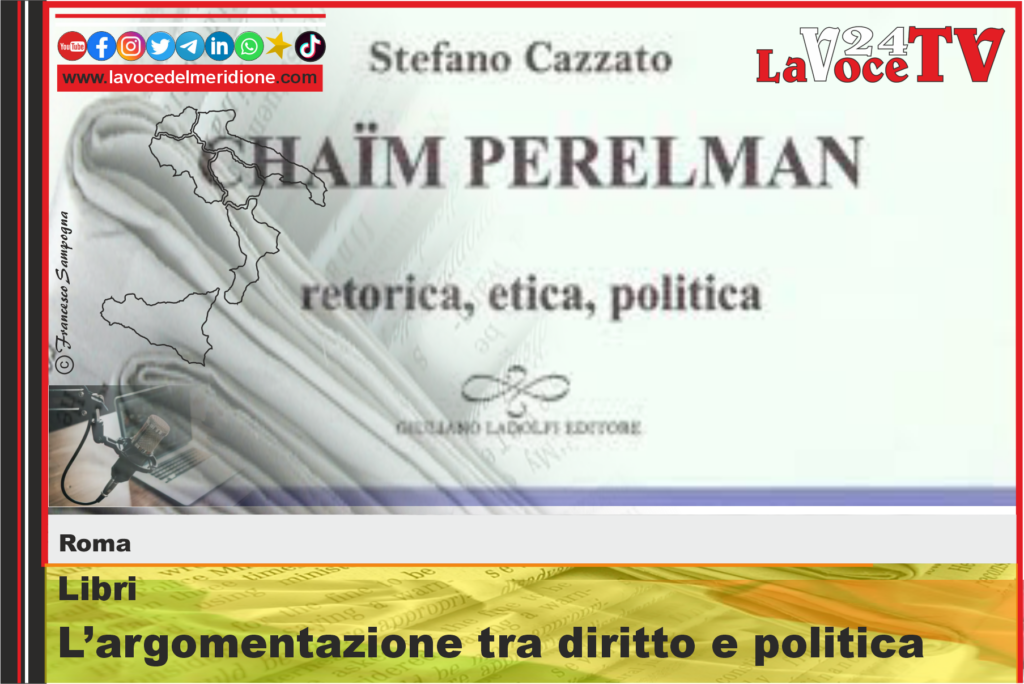
L’argomentazione tra diritto e politica

di Giovanni De Gennaro
Il saggio di Stefano Cazzato “Chaïm Perelman, retorica, etica, politica” (Ladolfi, 2024) si presenta come testo fondamentale nell’affrontare le tematiche cruciali di Perelman, omaggiandone la figura, quale pilastro del secolo scorso e protagonista della Seconda guerra mondiale.
Ci spiega Cazzato, che Perelman, autore del “Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique” del 1958, scritto a due mani con Lucie Olbrechts-Tyteca, è da considerarsi come il filosofo che ha maggiormente contributo alla rinascita della retorica nel secolo scorso, grazie proprio al suo contributo nel campo della teoria dell’argomentazione, vista come critica alle visioni razionalistiche della filosofia moderna.
Critica questa, che si esprime proprio come opposizione alla visione formale e rigida della logica sviluppata nella filosofia moderna da filosofi come Kant e Descartes, che attribuivano un ruolo predominante alla ragione astratta ed universale, in netta contrapposizione con la “teoria dell’argomentazione“; dove appunto si sosteneva che l’argomentazione non poteva essere ridotta alla stregua di sole regole logico-matematiche, ma al contrario doveva essere presa in considerazione la tesi secondo cui, la maggior parte delle decisioni umane si basa su valori, credenze e contesti sociali che non possono essere per nulla formalizzati in un modo assoluto.
La teoria dell’argomentazione ha avuto ripercussioni in numerosi campi; ad esempio i giudici nel prendere decisioni, non possono basarsi solo su criteri di pura razionalità ma debbono riferirsi ad una forma di argomentazione che tenga conto della complessità del caso e delle diverse possibili interpretazioni delle leggi. Ed è proprio per questo che Perelman ha avuto un grande ascendente sulla filosofia del diritto e sulla giurisprudenza contemporanea.
Più in generale la principale innovazione introdotta da Perelman con la “filosofia dell’argomentazione” è stata giustappunto la ridefinizione della retorica classica in un contesto moderno. Cioè, considerare la retorica non come un’arte manipolativa priva di fondamento razionale, ma come una parte fondamentale del ragionamento umano, che si rivolge ad un pubblico.
Il concetto di “pubblico universale“, cioè un’entità ideale alla quale ogni argomentatore deve rivolgersi cercando di costruire un discorso che possa essere astrattamente accettato da qualsiasi essere razionale, in realtà non esiste; piuttosto Perelman ci riporta l’assioma che gli argomenti sono rivolti a specifici pubblici, ognuno con i propri valori, credenze e pregiudizi. Da ciò si desume che la teoria dell’argomentazione è un processo dinamico, in cui l’obiettivo non è la verità assoluta, ma un ragionevole consenso. Pertanto, su tali basi il filosofo distinguerà tra due tipi di argomentazione, quella Dimostrativa “che segue le regole della logica formale e matematica” e quella Pratica “tipica del discorso giuridico, morale e politico, che punta a convincere il pubblico mediante un ragionamento fondato su valori condivisi.”
L’opera di Chaïm Perelman, ad oggi continua ad essere studiata, proprio per l’enorme contributo che ci lascia, reintroducendo appunto nella filosofia moderna l’importanza del ragionamento non formale e per la sua visione del diritto come pratica sociale basata su principi morali ed interpretativi. Cazzato, appunto con il suo saggio che vi invitiamo a leggere, fa comprendere come il pensiero di Perelman entri a gamba tesa ancora oggi nella vita di tutti i giorni; facendoci intuire come le decisioni che prendiamo, sia nella sfera pubblica che in quella privata, non sono altro che il risultato di una negoziazione continua tra valori, interessi e credenze divergenti.
Vi lasciamo infine con le conclusioni che Cazzato ci riporta alla fine del suo saggio nel capitolo “La funzione sociale del riso“, cioè sui tre casi più gravi, che possono attrarre sull’oratore ignaro dei principi fondanti della teoria dell’argomentazione, il biasimo degli uditori: 1) il caso in cui egli neghi un principio logico; 2) il caso in cui disconosca l’esistenza di un fatto; 3) il caso in cui metta in discussione una premessa già accettata. Beh spesso ancora oggi questi tre punti vengono malamente raggiunti per negligenza dell’oratore.