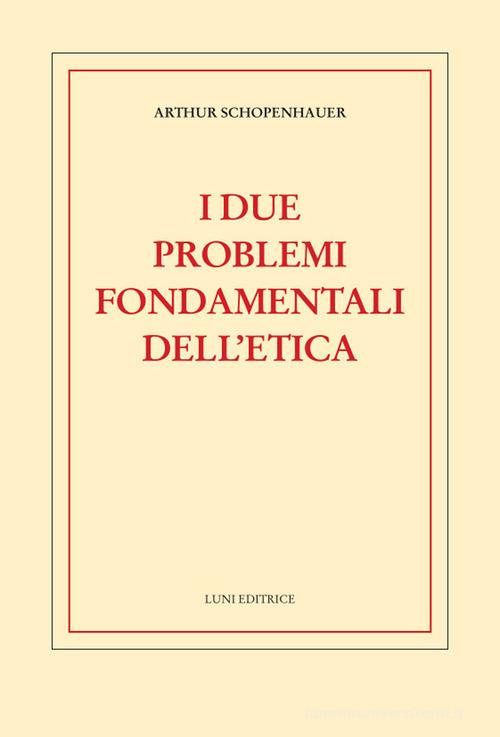Il piacere del testo: “Schopenhauer e l’uomo così com’è”
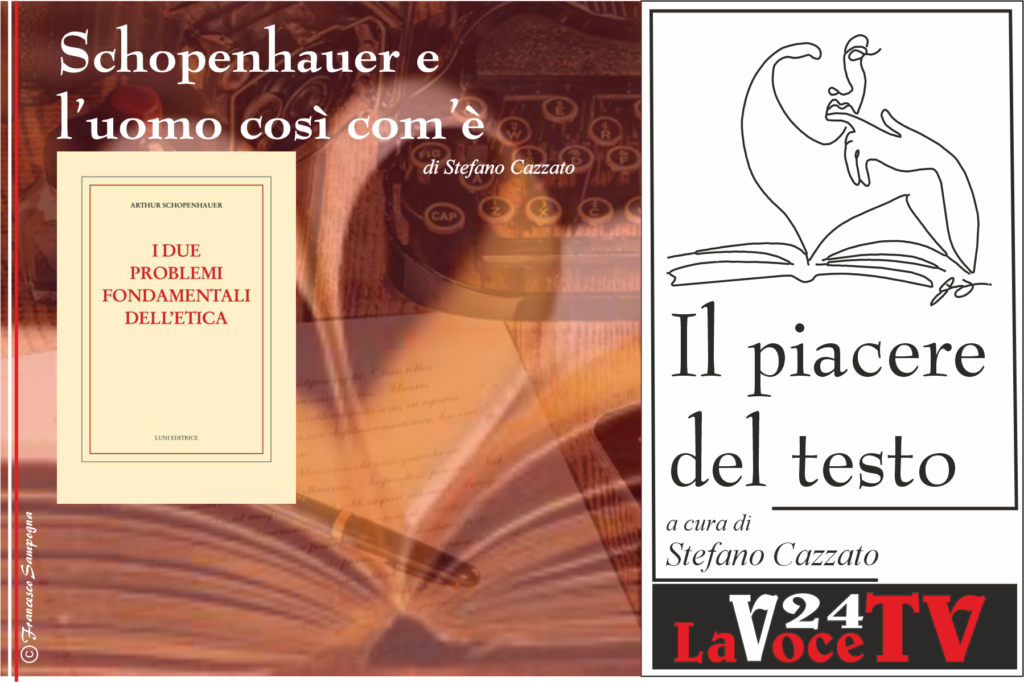

di Stefano Cazzato
Tradotto e curato da Sossio Giametta, uno dei maggiori conoscitori del pensiero di Schopenhauer, è uscito in questo 2024 per Luni editore un corposo volume che raccoglie le riflessioni del pensatore di Danzica sulla morale che non è solo un’appendice secondaria della sua teoria metafisica della voluntas, esposta in Il mondo come volontà e rappresentazione, ma un suo correlato essenziale: il modo in cui questo principio cieco e oscuro della voluntas opera oltre le apparenze fenomeniche ci dice chi realmente siamo, ci parla dell’uomo come è e non come dovrebbe essere, ci mette di fronte alle dinamiche e alle finalità umane, quelle alte e quelle bassissime, quelle nobili che ci permettono di sollevarci verso una specie di santità e quelle più volgari che ci abbasano a livello delle bestie. Con Schopenhauer cade il velo dell’illusione circa l’innata bonta dell’uomo. Prima di lui, solo Thomas Hobbes, inaugurando un’antropologia negativa, aveva insistito con fermezza su tale equivoco.
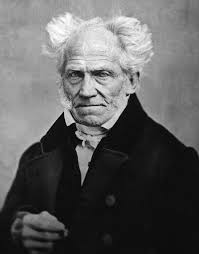
Se l’uomo è capace anche di gesti di carità e di solidarietà, di pietà e di abnegazione, purtroppo non è esente da passioni irrazionali come l’interesse, l’invidia e la cattiveria che lo mettono contro i suoi simili, ad eccezione dei propri cari ai quali generalmente riserva una cura particolare. Può persino essere buono l’uomo, ma solo quando le cose vanno come devono andare. Del resto “ci si troverebbe in un grande errore e molto ingenuo, se si credesse che tutte le azioni giuste e legali degli uomini fossero d’origine morale”.
Tre sono infatti per Schopenhauer i moventi della volontà: la malvagità, cioè volere il male dell’altro, l’egoismo cioè volere il proprio bene e la compassione, cioè volere il bene dell’altro.
Stabilire la quota che ognuna di queste spinte ha nelle azioni umane è molto difficile, ma è innegabile che la vita morale con la sua capacità di migliorarsi o di peggiorarsi dipende dal rapporto variabile che si instaura tra queste tre molle, ciascuna delle quali oscilla tra un minimo e un massimo: la malvagità infatti “va sino alla crudeltà” mentre la compassione “va sino alla nobiltà d’animo e alla magnanimità”.
Ci troviamo di fronte a una pessimistica dissezione della coscienza, che non annulla del tutto il libero arbitrio e la sua capacità di volgersi al bene, ma lo ridimensiona alla luce di forze che oggi, senza timore di essere smentiti, potremmo definire biologiche o libidiche. L’uomo potrà anche redimersi dalla sua costituzione irrazionale, ma in che misura e per quanto? Fino a che punto la ragione potrà avere la meglio sugli istinti? L’educazione e la civilizzazione non sono esse stesse freni fenomenici, individualizzati e temporanei, della perdurante, eterna e universale voluntas?
Sono le domande di sempre che il filosofo di Danzica, nel suo linguaggio tipicamente kantiano, si pone in questo classico irrinunciabile della filosofia che precorre l’esistenzialismo, le filosofie vitalistiche e la psicanalisi e che fornisce anche una brillante analisi della vita del desiderio e del piacere.
Arthur Schopenhauer, I due problemi fondamentali dell’etica, Luni editrice, pp. 800, 2024